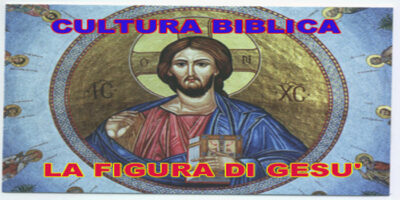Gesù sebbene manifestasse con sicurezza chi fosse, parlava raramente della sua condizione e non mostrava mai un disperato bisogno di definire se stesso. Al contrario rivendicava apertamente una straordinaria coscienza di se stesso quale inviato di Dio, suo Padre e la convinzione del potere di perdonare i peccati. Neanche Giuseppe Flavio, né gli scritti rabbinici, né la letteratura pagana riuscirono a capire all’epoca a quale categoria appartenesse. Né Gesù faceva di sé l’oggetto diretto della sua predicazione, poiché la sua identità era incorporata e definita dalla sua missione incentrata sulla venuta del Regno di Dio sulla terra, sulla misericordia del Padre e la riunione del popolo d’Israele. Gesù aveva Dio come oggetto centrale della sua predicazione, ma affermando la sua provenienza divina, quale Figlio di Dio, si proclamò quale mediatore finale tra Dio e il mondo nel ‘Progetto della Salvezza’. Affermava che Egli stesso sarebbe stato il criterio usato per il giudizio finale sulla base di come i suoi ascoltatori avrebbero reagito alle sue parole.
L’interesse fondamentale che anima gli evangelisti è di evidenziare l’immagine di un Gesù che, posto al centro del progetto salvifico di Dio, si pone al di sopra dei profeti e della legge mosaica; è quella di descrivere un Gesù quale figura centrale del dramma escatologico che egli annunciava e inaugurava, consapevole che il dramma della croce avrebbe chiarito definitivamente la sua vera identità di Figlio di Dio. Durante la sua attività pubblica Gesù ha dovuto combattere per preservare la sua identità e la sua missione sia da ‘tentazioni esterne’ che da ‘tentazioni interne’. Le tentazioni esterne erano legate all’ambiente in cui operava, come le attese trionfalistiche di un Messia terreno che, dopo il prodigio della moltiplicazione dei pani, avevano indotto la folla a proclamarlo re. Gesù ha dovuto allontanare la tentazione satanica rifugiandosi in un monte a pregare. Anche nel suo intimo si svolse una lotta drammatica: l’episodio del monte degli Ulivi descrive da una parte la consapevolezza razionale di sfuggire ad una morte violenta, dall’altra la spinta interiore e la determinazione a fare la volontà del Padre per portare a compimento il progetto divino della salvezza.
L’indagine condotta su Gesù attraverso l’analisi dei testi evangelici ci permette di cogliere sicuramente tratti salienti della sua immagine. Ma è altrettanto vero che, come attestano gli scritti del Nuovo Testamento, lo storico ebreo Giuseppe Flavio, gli scritti rabbinici e la letteratura pagana, nessuno è mai riuscito a capire chi fosse realmente Gesù. Il dato notevole è che Gesù rientra in molte categorie religiose del tempo, ma in realtà nessuna di esse si adatta in maniera esaustiva per attribuire alla persona di Gesù un titolo e una definizione ben precisa. L’interezza della sua immagine rimane costantemente avvolta dal mistero!
Uno degli aspetti più emblematici da evidenziare è che Gesù palesa una chiara e straordinaria coscienza di sé, rivendicando una posizione e un ruolo unici nel punto culminante della storia d’Israele. Nella sinagoga di Nazareth si auto-qualifica come profeta che parla a nome di Dio; rivendica apertamente di essere un inviato da Dio e di possedere poteri divini; agisce nel presupposto che egli stesso sarebbe stato il criterio usato per il giudizio finale. I suoi ascoltatori sarebbero stati giudicati l’ultimo giorno a seconda di come reagivano alle parole di Gesù, nel senso di accoglienza o di rifiuto. Tutto questo implicava per Gesù un’enorme rivendicazione di diritto e un ruolo unico nel punto culminante della Storia di Israele. Nel dichiarare espressamente la sua natura divina si arroga la funzione unica di rivelare agli uomini il vero volto di Dio e di conoscere direttamente quale fosse la sua volontà in ogni concreta situazione: una rivendicazione ricapitolata nelle sue ricorrenti e solenni affermazioni ‘in verità, in verità di dico’. Ma Gesù non solo rivendica le sue origini divine, ma afferma anche di avere Dio per Padre. Bastano solo alcune citazioni dei Vangeli: «non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 2,49); «non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato» (Gv 2,16); «entrerà nel regno dei cieli colui che fa la volontà del Padre mio» (Mt 7,21).
È peculiare l’intenzione di Gesù nel voler svelare progressivamente la sua identità durante la sua predicazione. Impone il silenzio ai suoi discepoli e ai miracolati di fronte ai prodigi e alle guarigioni più significative. Si tratta del cosiddetto ‘segreto messianico’ che viene spiegato da Gesù seguendo una propria metodologia, mirata ad evitare che i suoi interlocutori cadano in equivoci o in traumi di fronte all’annuncio di un radicale cambiamento di prospettiva. Forse è anche questo il motivo per cui Gesù, nonostante abbia mostrato di sé una immagine chiara e inequivocabile, non ha voluto dare una diretta e specifica identificazione di se stesso.
Gesù non utilizza mai il termine di Messia per autodefinirsi, anzi quando sono altri ad utilizzarlo impone il silenzio. L’unico appellativo più ricorrente nei Vangeli con cui Gesù definisce se stesso è “Figlio dell’uomo”, una espressione enigmatica ed oscura, che nel linguaggio ebraico indica semplicemente “un uomo” e che ricorre nei Vangeli solo in bocca a Gesù per auto-designarsi. Nel vangelo di Marco questa espressione compare per 14 volte; nei Vangeli in totale l’espressione “Figlio dell’uomo” si ritrova ben 82 volte, solo ed esclusivamente in bocca a Gesù. Tale espressione non è nuova nella terminologia biblica, perché viene assunta nel libro di Daniele (7,13-14) per descrivere una figura messianica che sintetizza i tratti della gloria, della potenza e del giudizio definitivo “Ed ecco arrivare sulle nubi del cielo, uno, simile a figlio di uomo; a lui furono dati potere, gloria e regno; il suo potere è un potere eterno tale che non sarà mai distrutto”. La visione del veggente descritta nel libro del profeta Daniele si presta ad essere collegata con la figura del Messia tanto atteso dalla comunità ebraica, e in tal senso possiamo dire che Gesù vi si poté riallacciare. Questa espressione con cui Gesù nascose il suo ministero e al tempo stesso lo rese gradualmente accessibile, non esisteva nel giudaismo prima del tempo di Gesù, era nuova e assolutamente originale per l’epoca in cui visse Gesù e per questo sembra probabile che questa locuzione risalga in qualche modo a Gesù. E’ singolare, infatti, che gli scrittori del Nuovo Testamento, compreso gli evangelisti, non citano Gesù con l’appellativo di <Figlio dell’uomo>, ma con i titoli di Messia (Cristo) e di Figlio di Dio. È naturale chiedersi perché Gesù durante la sua predicazione abbia optato di questo titolo per auto-designarsi. Poteva benissimo autodefinirsi semplicemente “Figlio di Dio”, considerato che si era dichiarato un inviato da Dio, il Padre. Probabilmente l’espressione <Figlio dell’uomo> si inseriva perfettamente nel modo e nello stile della predicazione di Gesù che si esprimeva spesso attraverso parole enigmatiche e parabole per esprimere il suo originale rapporto con la storia e il destino degli uomini. Le questioni riguardo al fatto se Gesù storico abbia usato tale appellativo e in quale senso lo abbia usato sono tutt’ora oggetto di dibattiti tra teologi e biblisti. Secondo gli studiosi Gesù utilizzava questa espressione enigmatica “Figlio dell’Uomo” sul genere delle parabole per far riferimento in modo paradossale a se stesso, a seconda delle circostanze e dei contesti che caratterizzavano tratti del suo ministero, relazionandola con se stesso quale umile portatore del regno di Dio, e con la sua attività: come le difficoltà della predicazione in un ambiente ostile, l’apparente fallimento della sua missione, la sua sofferenza, la predizione esplicita della sua passione e morte, la sua glorificazione. In sintonia con il segreto messianico, teso a svelare progressivamente la totalità della sua immagine all’interno di un mistero più grande, questa espressione “Figlio dell’uomo” forse lo aiutava ad evitare di dare una diretta e palese identificazione di sé quale “Figlio di Dio”.
Nell’enigmatica espressione “Figlio dell’uomo” si racchiude l’essenza propria della figura di Gesù, della sua missione e del suo essere, del mistero dell’identità che Gesù fa di se stesso (Gesù-Vero-Dio). Egli proviene da Dio, Egli è Dio. Ma assumendo la natura umana (Gesù-vero-uomo) porta la vera umanità (Benedetto XVI).